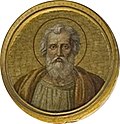domenica 24 agosto 2025
PIACENTINI GIORGIO
PIACENTINI GIORGIO (1902 - 1969)
Ferrara omaggia la memoria di Giorgio Piacentini (1902 - 1969), Cavaliere del Lavoro, imprenditore e filantropo. Oggi è stata infatti intitolata a lui la rotatoria tra via Caldirolo e via Gaetano Turchi, che si trova a pochi passi da quella che fu un tempo la sede del calzaturificio Zenith, divenuto sotto la guida di Piacentini un'eccellenza manifatturiera e industriale del panorama produttivo italiano nel dopoguerra.
La cerimonia di intitolazione è in programma questa mattina, alla
presenza per l’Amministrazione Comunale dell’assessore Stefano Vita
Finzi e dei familiari di Giorgio Piacentini. La proposta di
intitolazione, su suggerimento di Carlos Dana, nipote di Giorgio
Piacentini, e del pronipote Giorgio Pizzirani, è stata approvata dalla
Commissione cittadina per la Toponomastica e dalla Giunta comunale e,
infine, autorizzata dalla Prefettura di Ferrara.
“Con questa intitolazione il Comune di Ferrara rende omaggio al
nome e alla storia di un personaggio che ha impegnato tutta la sua vita a
favore dell'industria ferrarese, anticipando concetti e azioni quali il
welfare aziendale e iniziative di carattere culturale e sociale,
rivolte a tutto il territorio, come con l’istituzione del Premio Estense
e del Cineclub Fedic Ferrara. Si tratta di un piccolo gesto, che ha per
noi però un grande valore: ricordare questa importantissima figura
attribuendogli un luogo di Ferrara, che tanto ha amato, vicino a quello
che è stato il suo universo professionale e umano. Ringrazio la famiglia
per essere presente oggi e per essersi prodigata nell’operazione di
intitolazione. L’augurio è che la figura di Giorgio Piacentini che possa
essere modello ed esempio per tutti noi”, così l’assessore Stefano Vita
Finzi Zalman, che ha ringraziato per il lavoro l’ufficio Toponomastica
del Comune di Ferrara.
Figlio di proprietari terrieri della Bassa Ferrarese, sposato con
Jolanda Buzzoni nel 1925, Giorgio Piacentini divenne industriale di
primo piano a seguito della scomparsa del suocero Edgardo Buzzoni,
avvenuta nel 1928. Raccolse infatti l’eredità imprenditoriale fondando e
diventando titolare della Zenith, insieme al cognato Andrea. Nelle sue
mani, infatti, l'azienda decollò diventando leader nel settore delle
calzature eleganti da uomo e da bambino, con esportazioni record in
America e non solo. Se nel 1929 le maestranze occupate sono 135, con una
produzione quotidiana di 160 paia di calzature, nel 1943 la Zenith
raggiunge i 510 dipendenti, raggiungendo una produzione di 2250 paia di
scarpe al giorno, di cui in alta percentuale sono di tipo militare.
La guerra fu un durissimo scoglio per i Buzzoni-Piacentini, come
riportano le cronache del tempo. Lo stabilimento viene bombardato più
volte e duramente, tanto che a fine del conflitto la fabbrica si trova
rasa al suolo, con trecento operai senza lavoro. Dopo la Liberazione
Piacentini affronta la ripresa dell’attività in locali di fortuna. Sul
finire del 1948 viene decisa la costruzione del nuovo stabilimento in
via Caldirolo al civico 84, che sarà ultimata nel 1950. Il nuovo
opificio dà da lavorare a 500 unità tra operai e impiegati con una
produzione giornaliera di circa 800 paia di calzature. “La complessa
costruzione industriale, sorta in un'area di 23mila metri quadri,
costituisce quanto di più razionale può riunire in sé uno strumento
produttivo di tale importanza. Perché non solo il dott. Piacentini ha
cercato con il riammodernamento degli impianti e una geniale
distribuzione del lavoro di organizzare il ciclo produttivo secondo i
più recenti dettami della tecnica moderna, ma si è parimenti preoccupato
che il nuovo complesso fosse dotato di servizi ausiliari e igienici:
mense, spaccio, ambulatorio medico e biblioteca, attuato con criteri
organici e confortevoli", come si legge in un interessante ritratto di
Piacentini, che emerge dai documenti conservati negli archivi della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Attenzione viene posta
anche al welfare aziendale, con l’invio in colonia per oltre 50 bambini
dei lavoratori “a totale carico della Zenith”, “anticipazioni ai capi
famiglia per l’acquisto di appartamenti” e donazione a ciascun operaio
di una ‘sporta’ contenente ogni genere di vettovaglia per Natale e
“cospicui premi in denaro”.
Ma il nome di Giorgio Piacentini non è solo legato alla vicenda
economica e imprenditoriale di Ferrara. Fu infatti sua l’idea, mentre
era presidente provinciale dell’Unione industriali, di fondare il Premio
Estense, la cui prima edizione si svolse nel 1965.
Anche il Cineclub Fedic Ferrara fu fondato qualche anno prima,
nel 1953, per iniziativa di Piacentini. Il circolo di cultura
cinematografica ferrarese fu riconosciuto come il migliore d’Italia già
pochi anni dopo, nel 1956 e anche nel 1957.
Istituì negli stessi anni anche un asilo infantile a Fossanova
San Marco, borgo che era divenuto residenza della famiglia Piacentini.
La struttura scolastica viene considerata tra le migliori della
provincia, con oltre 350 metri quadri di area coperta che consente
l'assistenza di 150 bambini della zona e dispone di sale per lavoro e
doposcuola.
Quanto sopra tratto da:
ARCHIMEDE
Alcune notizie su Archimede tratte dal sito, (come solito), di Wikipedia al quale vi rimandiamo se volete approfondire l'attività del matematico, fisico e ............
https://it.wikipedia.org/wiki/Archimede
Archimede di Siracusa (in greco antico: Ἀρχιμήδης?, Archimédēs; Siracusa, 287 a.C. circa – Siracusa, 212 a.C.[1]) è stato un matematico, fisico e inventore siceliota.
Considerato come uno dei più grandi scienziati e matematici della storia, contribuì ad aumentare la conoscenza in settori che spaziano dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla meccanica: fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e formulò le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi; in campo ingegneristico, scoprì e sfruttò i principi di funzionamento delle leve e il suo stesso nome è associato a numerose macchine e dispositivi, come la vite di Archimede, a dimostrazione della sua capacità inventiva. Circondate ancora da un alone di mistero sono invece le macchine da guerra che Archimede avrebbe preparato per difendere Siracusa dall'assedio romano.
La sua vita è ricordata attraverso numerosi aneddoti, talvolta di
origine incerta, che hanno contribuito a costruire la figura dello
scienziato nell'immaginario collettivo. È rimasta celebre nei secoli, ad
esempio, l'esclamazione èureka! (εὕρηκα! - ho trovato!) a lui attribuita dopo la scoperta del principio sul galleggiamento dei corpi che ancora oggi porta il suo nome.
Il principio del sollevamento della vite di Archimede
domenica 10 agosto 2025
Via Cisterna del Follo, a Ferrara, inizia dall'incrocio tra via Savonarola, via Madama e via Ugo Bassi ed arriva a viale Alfonso I d'Este, vicino al Baluardo di San Tommaso.
Storia

L'area dove si trova la via fu interessata dall'opera di ampliamento di Biagio Rossetti nell'ambito dell'addizione voluta da Ercole I d'Este. In quell'area, che corrisponde circa al luogo dove poi venne edificata la prospettiva di corso Giovecca, esisteva già dal 1370 il Canton del Follo. Più tardi un genovese, tale Urbano Trincherio, impiantò nella zona una fabbrica di panni d'oro e di broccati e per la lavorazione della seta.
Altre notizie storiche sulla strada si hanno da quando vi fu costruito un palazzo per Nerone Diotisalvi nel 1470 dopo che questi era fuggito da Firenze nel 1460 perché coinvolto in una congiura contro i Medici e accolto in Ferrara da Borso d'Este.
Sempre su questa via era presente una chiesa ed un convento di monache Servite.
Origini del nome
In tempi passati fu chiamata via Diotisalvi dal Diotisalvi che qui vi costruì il palazzo in seguito noto come palazzo Bonacossi.
Il nome di cisterna del Follo prende origine probabilmente nel XIV secolo quando nella via esisteva un pozzo (o una cisterna) utilizzato per lavare la lana grezza e per follare i panni, cioè battere la lana ed infeltrirla rendendo più compatto il suo pelo. La via quindi, assieme a poche altre in città, conserva ancora traccia nel suo nome degli antichi mestieri artigianali che facevano parte delle attività legate alle antiche corporazioni delle arti e mestieri.
From:
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Cisterna_del_Follo
Dal Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli:
- FOLLARE : sottoporre a follatura i tessuti di lana;
- FOLLATURA:
1 - operazione con la quale si fanno restringere e assodare i panni di lana sottoponendoli a pressione, a sfregamento e ad azioni chimiche in bagni alcalini o acidi.
2 - pigiatura dell'uva. Pratica enologica consistente nel risospingere al fondo delle botti le vinacce che, durante la fermentazione, vengono a galla, al fine di ottenere una migliore vinificazione del mosto, e quindi vini più limpidi e purgati.
GIOVANNI PASCOLI
GIOVANNI PASCOLI nacque nella casa materna di San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855. Figlio quartogenito di Caterina Vincenzi Alloccatelli e di Ruggero Pascoli, ebbe come fratelli Margherita, Giacomo, Luigi, Raffaele, Giuseppe, Ida e Maria (altre due sorelle, Ida e Carolina, morirono in tenera età). Visse felicemente i primi anni della sua vita nella casa natale di San Mauro, trascorrendo giorni spensierati nella tenuta dei Principi Torlonia chiamata “La Torre” che il padre Ruggero amministrava.
Nel 1862, all’età di sette anni, Giovanni cominciò a frequentare, insieme ai fratelli maggiori Giacomo e Luigi, il collegio dei Padri Scolopi di Urbino, dove resterà fino ai sedici anni.
Il 10 agosto 1867, il padre venne ucciso in un agguato (il mandante non verrà mai incriminato) mentre ritornava da Cesena col suo calesse trainato dalla fedele cavallina storna. Questo lutto ed altre disgrazie familiari lasciarono profondamente il segno nella vita e nell’opera del poeta. Dopo la morte del padre, la famiglia si raccolse nella casa nativa di San Mauro; l’anno dopo morì la sorella Margherita e pochi mesi dopo anche la madre. Seguirono lunghi periodi di grandi ristrettezze. Giovanni ritornò nel collegio di Urbino, ma nel 1871, a causa dei debiti della famiglia, fu costretto a lasciarlo.
Proseguì gli studi liceali a Rimini, poi a Firenze, conseguendo la maturità a Cesena.
Nel 1873 vinse una Borsa di studio presso l’Università di Bologna, guadagnandosi la stima e la protezione del Carducci. In seguito, perse il sussidio per aver partecipato ad una manifestazione politica e dovette trascorrere 107 giorni in carcere, non potendosi iscrivere al terzo anno di studi. Uscì dal carcere con una visione diversa del mondo e della vita, rinnovata nel sentimento del destino comune di infelicità, che rende inutile l’odio tra gli individui.
Nel 1876, dopo la morte del fratello Giacomo, conobbe Andrea Costa e si avvicinò al Socialismo.
Nel 1880, nuovamente ottenuto il sussidio, riprese gli studi e nel 1882 si laureò con una tesi su Alceo. Iniziò quindi la sua carriera di insegnante e di letterato. Insegnò ai licei di Matera, Massa e Livorno; ebbe un incarico straordinario all’Università di Bologna, poi fu professore alle Università di Messina, Pisa e Bologna.
Nel 1885, realizzando il desiderio delle sorelle di ricostruire il “nido” di San Mauro, portò con sè a Massa Ida e Maria, che si trovavano a Sogliano presso la zia Rita.
Nel 1892 partecipò al concorso di poesia latina di Amsterdam con il poemetto Veianius, vincendo il primo premio (una medaglia d’oro massiccio): la prima di altre dodici, sempre dello stesso premio olandese. Più tardi acquistò una villa a Castelvecchio Barga, dove visse con la sorella Maria fino alla fine dei suoi giorni.
Nel 1905 fu chiamato a succedere al Carducci nella Cattedra di Letteratura Italiana all’Università di Bologna.
Morì a Bologna il 6 aprile 1912. Con lui si spegne una delle sensibilità umane più complesse ed una delle voci poetiche più singolari del Novecento.
FROM:
https://www.accademiapascoliana.it/vita-di-giovanni-pascoli/
10 AGOSTO - poesia di Giovanni Pascoli
10 AGOSTO
San Lorenzo, Io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.
Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.
Ora è là come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.
Anche un uomo tornava al suo nido:
l’uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido
portava due bambole in dono…
Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male!
La poesia che commemora il 10 agosto è "X Agosto" di Giovanni Pascoli. Questa poesia, scritta in memoria del padre Ruggero ucciso il 10 agosto 1867, riflette sul dolore e l'ingiustizia. Pascoli associa la notte di San Lorenzo, con le sue stelle cadenti, alla perdita del padre e alla morte della rondine, creando un legame simbolico tra la tragedia personale e il dolore universale.
Parafrasi X agosto
San Lorenzo, io so perché (oggi) così tante stelle splendono e cadono
nel cielo tranquillo e perché un così grande pianto brilla
nell’orizzonte concavo della notte.
Una rondine stava tornando al tetto, la uccisero e cadde tra i rovi: nel becco aveva un insetto, la cena per i suoi piccoli.
Adesso è lì, con le ali aperte come in croce, e dal becco porge ancora
il verme al cielo lontano. I suoi piccoli, nel nido, continuano ad
aspettarla nell’ombra e pigolano sempre più piano.
Anche un uomo stava tornando a casa: quando lo uccisero disse "Perdono" e
nei suoi occhi aperti rimase un grido; portava con sé due bambole, in
regalo.
Ora lì, nella casa solitaria, lo aspettano inutilmente: il suo corpo immobile e attonito mostra le bambole al cielo lontano.
(Ecco perché piangi:) Tu Cielo, infinito e immortale, dall’alto dei
mondi sereni in cui risiedi inondi di stelle questo nostro mondo, un
atomo opaco fatto di dolore.
giovedì 7 agosto 2025
ANTIPAPA
Elenco cronologico degli antipapi storici
Dal II secolo alla prima metà del XIV
Scisma d'Occidente
Linea avignonese
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio antipontificato | Fine antipontificato | Nome secolare | Opposto a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemente VII | 
|

|
20 settembre 1378 | 16 settembre 1394 | Roberto di Ginevra | Papa Urbano VI, Papa Bonifacio IX |
| Benedetto XIII[N 19] | 
|
16 settembre 1394 | 23 maggio 1423 | Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor |
| |
| Clemente VIII[N 20] | 
|
|
10 giugno 1423 | 26 luglio 1429 | Gil Sánchez de Muñoz | Papa Martino V, Antipapa Benedetto XIV (Garnier) |
| Benedetto XIV[N 21] |
|
|
12 novembre 1425 | 1430 | Bernard Garnier | Papa Martino V, Antipapa Clemente VIII |
| Benedetto XIV |
|
|
1430 | 1437 | Jean Carrier | Papa Martino V, Papa Eugenio IV |
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio antipontificato | Fine antipontificato | Nome secolare | Opposto a |
Linea pisana
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio antipontificato | Fine antipontificato | Nome secolare | Opposto a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro V[N 10] | 
|

|
26 giugno 1409 | 3 maggio 1410 | Pietro Filargo | Papa Gregorio XII, Antipapa Benedetto XIII |
| Giovanni XXIII[N 22] | 
|

|
17 maggio 1410 | 29 maggio 1415 | Baldassarre Cossa | |
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio antipontificato | Fine antipontificato | Nome secolare | Opposto a |
Dopo il Concilio di Costanza
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio antipontificato | Fine antipontificato | Nome secolare | Opposto a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felice V[N 23] | 
|
5 novembre 1439 | 24 luglio 1449 | Amedeo VIII di Savoia | Papa Eugenio IV, Papa Niccolò V |
Per approfondire visita il sito:
https://it.wikipedia.org/wiki/Antipapa
domenica 3 agosto 2025
UGO FOSCOLO
UGO FOSCOLO
Niccolò Foscolo, detto Ugo (Zante, 6 febbraio 1778 – Londra, 10 settembre 1827), è stato un poeta, scrittore, drammaturgo, traduttore, critico letterario e patriota italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo.
Fu uno dei più notevoli esponenti letterari italiani del periodo a cavallo fra Settecento e Ottocento, nel quale si manifestarono e cominciarono ad apparire in Italia le correnti neoclassiche e romantiche, durante l'età napoleonica e la prima Restaurazione.
Costretto fin da giovane ad allontanarsi dalla sua patria (l'isola greca di Zacinto/Zákynthos, oggi nota in italiano come Zante), allora territorio della Repubblica di Venezia, si sentì esule per tutta la vita, strappato da un mondo di ideali classici in cui era nato e cresciuto, tramite la sua formazione letteraria e il legame con la terra dei suoi antenati (nonostante un fortissimo legame con l'Italia, che considerava la propria madrepatria). La sua vita fu caratterizzata da viaggi e fughe, a causa di motivi politici (militò nelle forze armate degli Stati napoleonici, ma in maniera molto critica, e fu un oppositore degli austriaci, a causa del suo carattere fiero, dei suoi sentimenti italiani e delle sue convinzioni repubblicane), ed egli, privo di fede religiosa e incapace di trovare felicità nell'amore di una donna, avvertì sempre dentro di sé un infuriare di passioni.
Come molti intellettuali della sua epoca, si sentì però attratto dalle splendide immagini dell'Ellade, simbolo di armonia e di virtù, in cui il suo razionalismo e il suo titanismo di stampo romantico si stemperavano in immagini serene di compostezza neoclassica, secondo l'insegnamento del Winckelmann.
Tornato per breve tempo a vivere stabilmente in Italia e nel Lombardo-Veneto (allora ancora parte del Regno d'Italia napoleonico) nel 1813, partì presto in un nuovo volontario esilio e morì povero qualche anno dopo a Londra, nel sobborgo di Turnham Green. Dopo l'Unità d'Italia, nel 1871, le sue ceneri furono riportate per decreto del governo italiano in patria e inumate nella basilica di Santa Croce a Firenze, il Tempio dell'Itale Glorie da lui cantato nei Sepolcri (1806).
Per approfondire e per maggiori informazioni visita il sito: