TALASSEMIA - L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE E DELLA DONAZIONE DI SANGUE
Oggi una mia conoscente affetta da grave malattia genetica mi ha comunicato che non ha potuto effettuare le trasfusioni necessarie per continuare a vivere per mancanza di sangue.
Perchè non diventi donatore anche tu?
Sono già tante, ma non sufficienti, le persone che con un piccolo gesto danno la possibilità di continuare a vivere a chi è affetto da gravi malattie. A tutte queste persone il mio più grande riconoscimento e ringraziamento.
Nonno Kucco
Il sangue è un insostituibile alleato negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche.



Se risulti idoneo, sei pronto per la tua prima donazione.
Per approfondire:
https://www.avis.it/chi-siamo/dati-donazioni/LORETA PIETRO
Da: https://storiaememoriadibologna.it/archivio/persone/loreta-pietro
Nato a Ravenna da famiglia nobile trasferitasi poi a Bologna, fin da ragazzo coltivò ideali patriottici; partecipò alla battaglia dell'8 agosto 1848 alla testa del Battaglione della Speranza, una formazione istituita per addestrare gli adolescenti alla vita militare e l'anno successivo, durante la Repubblica Romana, fu capitano della Guardia Civica. Nel 1850 si iscrisse alla facoltà di Medicina e chirurgia e durante l'epidemia di colera del 1855 si offrì come volontario per prestare servizio nel lazzaretto, rimanendovi per tutto il periodo del contagio. Laureatosi in chirurgia nel 1856 e in medicina nel 1858, iniziò a lavorare come medico condotto nelle Marche finché, nel 1861, l'anatomista Luigi Calori non lo richiamò a Bologna, per collaborare con lui come dissettore anatomico. In quegli anni ricoprì anche il ruolo di maggiore chirurgo della Cavalleria della Guardia Nazionale.
Nel 1866 partecipò alla terza Guerra di Indipendenza come ufficiale medico dei volontari garibaldini e si distinse particolarmente nella battaglia di Ampola, venendo promosso capitano e ricevendo una medaglia al valore. L'anno dopo fu nominato chirurgo a Fermo, ma già alla fine del 1868 veniva chiamato dall'Università di Bologna per insegnare clinica chirurgica e dirigere il relativo istituto, iniziando così la sua carriera accademica; nel 1871 fu nominato ordinario di Clinica chirurgica, succedendo a Francesco Rizzoli; dal 1878 al 1881 insegnò inoltre patologia speciale chirurgica e dal 1885 fu presidente della Società Medico-chirurgica di Bologna. Chirurgo abile, al tempo stesso ardito e prudente, Loreta eseguì interventi in tutti i settori della chirurgia, soprattutto all'addome: da segnalare quello su un aneurisma dell'aorta addominale (1884) e la prima resezione di un lobo del fegato (1887); ideò e costruì inoltre nuovi strumenti chirurgici per adattarli alle proprie tecniche, pubblicando poi i risultati dei suoi lavori in numerosi articoli di carattere innovativo, ricevendone premi e riconoscimenti. Venne nominato commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, e nel 1887 fu eletto deputato (sul suo nome convennero i due schieramenti, moderato e progressista), anche se partecipò poco ai lavori del Parlamento. In occasione dell'Esposizione Emiliana (1888) fu membro del Comitato esecutivo e Presidente della Commissione per organizzare il Tempio del Risorgimento. Negli ultimi anni il suo carattere introverso e cupo si accentuò, fino a degenerare in vera e propria mania di persecuzione: giunse a isolarsi da tutti, entrando in contrasto coi suoi assistenti, e infine si tolse la vita. Nel 1892 gli fu dedicato un ricordo in marmo nell'anfiteatro della Clinica Chirurgica dell'Ospedale Sant'Orsola, e nel 1931 fu posta una lapide sulla casa dove abitò e morì, in via Santo Stefano. Anche una strada cittadina, nei pressi dello stesso Ospedale, è intitolata a Loreta. Presso il Museo del Risorgimento è infine conservata – oltre ad alcuni suoi documenti - l'uniforme garibaldina che utilizzò nel 1866.
Otello Sangiorgi
Foto scattata il 21 giugno 2024 nell'atrio del Padiglione 27 dell'Ospedale S.Orsola di Bologna.
Il trattamento "ha il potenziale per trasformare la vita dei pazienti affetti da queste due patologie; ora è importante che questa terapia sia messa rapidamente a disposizione dei pazienti eleggibili", ha affermato Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e sperimentatore principale di due degli studi che hanno portato all'approvazione.
L'anemia falciforme e la beta talassemia sono entrambe malattie ereditaria del sangue che colpiscono i globuli rossi inficiando la loro capacità di trasportare l'ossigeno agli organi e i tessuti del corpo. Entrambe richiedono un trattamento a vita e causano una diminuzione della qualità e dell'aspettativa di vita. Attualmente, una delle possibili potenziali cure è il trapianto di cellule staminali da donatore compatibile, ma questa opzione è disponibile solo per una piccola percentuale di pazienti.
La nuova terapia il cui nome è exagamglogene autotemcel [exa-cel] è la
prima terapia di editing genico basata sul sistema CRISPR/Cas9. Questa
tecnologia consente di modificare geneticamente le cellule staminali e
progenitrici ematopoietiche del paziente portando alla produzione di
alti livelli di emoglobina fetale nei globuli rossi. Nelle
sperimentazioni, il trattamento ha ridotto o eliminato le crisi
vaso-occlusive e ridotto la necessità di trasfusioni.
Il
prodotto potrà essere utilizzato nei pazienti con almeno 12 anni affetti
da beta-talassemia dipendente dalle trasfusioni o da anemia falciforme
severa caratterizzata da crisi vaso-occlusive ricorrenti, per i quali è
appropriato il trapianto di cellule staminali ematopoietiche ma non è
disponibile un donatore consanguineo compatibile. Si stima che siano
circa 8 mila i pazienti in Europa potenzialmente eleggibili al
trattamento.
Guariti grazie alle “forbici” molecolari in grado di correggere i difetti del DNA. Sono i pazienti con talassemia e anemia falciforme coinvolti in due studi internazionali, pubblicati ora sullo stesso fascicolo della rivista New England Journal of Medicine, che hanno visto l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tra i centri di ricerca protagonisti della sperimentazione, basata sulla tecnica di editing genetico nota con il nome di CRISPR-Cas9.
Il 91% dei pazienti talassemici – documentano gli
studi – ha raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni periodiche, che
per i soggetti con affetti da questa malattia sono necessarie per
mantenere adeguati i valori di emoglobina nel sangue. Il 97% dei
pazienti con anemia falciforme è divenuto invece libero dalle crisi
vaso-occlusive, che possono provocare complicanze gravi e fortemente
invalidanti. Per il prof. Franco Locatelli, che ha coordinato in
particolare la sperimentazione sulla talassemia, si tratta di «una
pietra miliare nella storia del trattamento di queste patologie»
L’EDITING DEL GENOMA
L’editing
del genoma con il sistema CRISPR-Cas9 è una tecnologia innovativa che
valse il Nobel per la Chimica nel 2020 alle scienziate Emmanuelle
Charpentier e Jennifer A. Doudna. Funziona come un “correttore” del DNA
ad altissima precisione. Il metodo si basa sull’impiego della proteina
Cas9, una sorta di forbice molecolare che viene programmata per tagliare
o modificare specifiche sequenze del DNA di una cellula, potendo così
portare – potenzialmente – alla correzione di varie malattie.
CRISPR-Cas9 è un complesso di molecole biologiche formato da frammenti
di RNA (acido ribonucleico) e da proteine: il segmento di RNA è la
bussola che indica il bersaglio da colpire, la proteina Cas9 esegue il
taglio o la modifica. Le cellule prelevate dalla persona malata vengono
“corrette” in laboratorio con questo approccio, poi vengono infuse
nell’organismo dove si riproducono al posto di quelle difettose.
TALASSEMIA E ANEMIA FALCIFORME
La
talassemia e l’anemia falciforme sono le due malattie ereditarie del
sangue più frequenti al mondo. In Italia si contano 7000 pazienti
talassemici, che dipendono regolarmente da trasfusioni, mentre i
pazienti falcemici si stima che siano circa mille, a fronte di 300.000
nuovi nati nel mondo ogni anno. 100.000 i falcemici che vivono negli
Stati Uniti d’America, ma il 75% dei bambini con questa patologia nasce
nell’Africa Subsahariana. A differenza dei falcemici che nascono nei
paesi economicamente più avanzati, con una prospettiva di vita intorno
ai 50 anni, la loro probabilità di sopravvivenza difficilmente va oltre i
20-25 anni, per le complicanze legate alla loro condizione.
Entrambe
le patologie sono causate dalle mutazioni dei geni coinvolti nella
sintesi delle catene dell'emoglobina, la proteina dei globuli rossi che
trasporta ossigeno nell’organismo. Normalmente, nei soggetti adulti,
ogni molecola di emoglobina è formata da 4 catene proteiche: 2 catene
alfa e 2 catene beta. Nelle forme più gravi di talassemia il problema è
l’assenza o la marcatamente ridotta produzione di catene beta, che rende
inadeguati i livelli di emoglobina nel sangue tanto da dover ricorrere
regolarmente a trasfusioni in media ogni tre settimane e assumere tutti i
giorni un farmaco in grado di eliminare il ferro che altrimenti si
accumulerebbe. Nonostante vi sia stato nel tempo un indiscutibile
miglioramento nelle prospettive di sopravvivenza di questi pazienti, di
fatto essa rimane ancora oggi di 20-25 anni inferiore rispetto a quella
della popolazione sana. Con in più lo sviluppo, spesso, di complicanze
legate al sovraccarico di ferro, che possono essere di tipo
endocrinologico (diabete, ipotiroidismo o ridotta fertilità),
cardiologico o epatologico (fibrosi e addirittura cirrosi).
Nell’anemia
falciforme, invece, non è la quantità ma l’alterazione della struttura
delle catene beta che porta alla formazione di globuli rossi anomali, a
falce, che ostacolano flusso sanguigno e ossigenazione nei capillari
provocando crisi vaso-occlusive che possono determinare eventi
celebro-vascolari acuti, ipertensione polmonare, patologie renali o
quadri di ridotta funzione della milza. Anche in questo campo i
progressi della terapia medica sono stati importanti. Ma pure a fronte
di questi miglioramenti, difficilmente la prospettiva di vita dei
soggetti falcemici supera i 50-55 anni con complicanze, per alcuni di
loro, fortemente invalidanti che si sviluppano anche in età
relativamente giovane.
LE FORBICI MOLECOLARI SUL GENE BCL11A
Le
due sperimentazioni internazionali, promosse da Vertex Pharmaceuticals e
Crispr Therapeutics, si basano sull’osservazione di un gene, che si
chiama BCL11A, che svolge un ruolo fondamentale nella produzione di
emoglobina nel sangue al termine della vita fetale. Quella presente nel
feto, infatti, è un tipo di emoglobina diversa (chiamata appunto
emoglobina fetale), formata non da catene alfa-beta, ma da catene
alfa-gamma. Questa specifica molecola di emoglobina viene
progressivamente sostituita a partire dalla nascita, quando si attiva un
meccanismo, guidato dal gene BCL11A, che blocca la sintesi delle catene
gamma con la produzione, al loro posto, delle catene beta, responsabili
della malattia nei pazienti con talassemia e anemia falciforme.
Il
trattamento sperimentato nei due trial internazionali si basa proprio
sul ripristino della sintesi dell’emoglobina fetale tramite l’editing
del genoma. Le cellule staminali emopoietiche dei pazienti, prelevate
tramite aferesi e selezionate, vengono modificate in appositi laboratori
con il sistema CRISPR-Cas9 programmato per “spegnere” il gene BCL11A e
far ripartire la produzione di emoglobina fetale alfa-gamma, con i
benefici attesi. Dopo questa manipolazione genetica, le cellule
modificate vengono infuse nei pazienti che nel frattempo sono stati
sottoposti a una terapia farmacologica per “distruggere” il midollo, in
modo da fare spazio alle nuove cellule staminali ingegnerizzate che si
moltiplicheranno correggendo la malattia.
Sul NEJM nel 2021 erano
stati pubblicati i casi di un paziente talassemico e di un paziente
falcemico trattati con questo approccio, come dimostrazione “di
principio” dell'efficacia della terapia. Già allora l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù era coinvolto nella sperimentazione, che è poi
proseguita con lo sviluppo dei due studi multicentrici chiamati
CLIMB-111 e CLIMB-121, entrambi pubblicati oggi, dove sono stati
arruolati numerosi pazienti di età compresa tra i 12 e i 35 anni
trattati con questo approccio. Per il primo studio, dedicato ai pazienti
con talassemia, l’Ospedale pediatrico della Santa Sede è stato il
centro di coordinamento internazionale, con il prof. Franco Locatelli
prima firma, avendo coordinato lo studio e reclutato il maggior numero
di pazienti. Per il secondo studio, dedicato ai pazienti con anemia
falciforme, patologia che impatta soprattutto sui soggetti di colore, il
Bambino Gesù è stato il secondo centro internazionale per arruolamento
di pazienti, nonostante la partecipazione di numerosi centri
statunitensi.
I RISULTATI DEGLI STUDI CLIMB-111 E CLIMB-121
Lo
studio CLIMB-111 ha coinvolto a livello internazionale 52 pazienti con
talassemia di cui 14 arruolati dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma. 35 pazienti avevano un follow up di 16 mesi, considerato
sufficiente per valutare l’efficacia dell’approccio al momento della
presentazione dei risultati. 32 su 35 avevano ottenuto la completa
indipendenza trasfusionale, pari a una percentuale di poco superiore al
91%. Se si estendono i tempi del follow up, tutti e 52 i pazienti
coinvolti nello studio hanno ottenuto l’indipendenza trasfusionale,
definita come un valore di emoglobina maggiore o uguale a 9 grammi per
decilitro di sangue per almeno un anno di tempo. Il valore medio di
emoglobina
registrato nei pazienti è stato infatti pari a 13,1 grammi per
decilitro (11.9 grammi di emoglobina fetale). Sono valori persino
superiori di quelli osservati nei genitori, che sono portatori del
carattere di questa patologia autosomica recessiva (un figlio su quattro
eredita la malattia). Valori che persistono nel tempo, perché i livelli
di emoglobina registrati non diminuiscono nei pazienti con più lungo
follow up (4 anni fa la prima infusione) e anche la presenza delle
cellule editate, sia nel sangue periferico che nel midollo, non cambia
nel tempo e si mantiene stabile. Il profilo di sicurezza, infine, è del
tutto congruente con quello di un trapianto autologo e decisamente
migliore rispetto a quello che si associa al trapianto allogenico, che
infatti anche prima della messa a punto di questa nuova terapia veniva
limitato ai soggetti sino ai 12-14 anni, perché sopra questa fascia di
età i rischi del trapianto diventavano troppo elevati.
Nello studio
CLIMB-121 sulle anemie a cellule falciformi sono stati inclusi 44
pazienti (7 arruolati dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) anch’essi
tra i 18 e i 35 anni, con età media di 21 anni. In questo caso,
l’obiettivo atteso non era l’indipendenza dalle trasfusioni, ma
l’assenza di episodi vaso-occlusivi per almeno 12 mesi consecutivi. 30
di questi pazienti avevano un follow up sufficiente per essere valutati.
29 di loro, pari al 97%, sono diventati liberi da crisi vaso-occlusive.
Anche in questo caso i livelli di emoglobina di questi pazienti sono
decisamente buoni, con una percentuale di emoglobina fetale superiore al
40%. Ed anche in questo caso il beneficio risulta sostenuto nel tempo.
DUE NUOVE SPERIMENTAZIONI SUI MINORI DI 12 ANNI
Alla
luce di questi dati l’editing genetico con CRISPR-Cas9 per il
trattamento di talassemia e anemia falciforme si presenta oggi come
un’opzione terapeutica che funziona e che può essere offerta
teoricamente ad ogni paziente, perché non è condizionata dalla necessità
di avere un donatore compatibile (ogni paziente serve da donatore di sé
stesso). La terapia è stata approvata dalla Food and Drug
Administration e dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) per i pazienti
di età superiore ai 12 anni. Per i pazienti di età inferiore ai 12 anni
sono in corso due nuove sperimentazioni all’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, che ha già trattato due bambini talassemici e due bambini
falcemici con risultati incoraggianti, a conferma dell’efficacia della
terapia indipendentemente dall’età del soggetto.
“UNA PIETRA MILIARE”
Per
il prof. Franco Locatelli, responsabile dell’area clinica e di ricerca
di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto
Emopoietico del Bambino Gesù di Roma: «La pubblicazione congiunta dei
due studi su una rivista come il New England Journal of Medicine
rappresenta una sorta di pietra miliare per quello che è il cambiamento
di scenario terapeutico e il potenziale definitivamente curativo di
queste due patologie così diffuse nel mondo. Un risultato che dimostra
una volta di più la capacità e la determinazione dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù nell'investire in terapie innovative in grado di
cambiare la storia naturale di malattie così complesse. Questi studi
testimoniano come l'Ospedale presti attenzione a tutto quello che può
cambiare la probabilità di sopravvivenza e la qualità di vita dei malati
affetti da malattie genetiche».
Nel servizio di Filippo Pala, montaggio di Mariangela Fedele, l'intervista a Franco Locatelli - Responsabile Oncoematologia e Terapia Cellulare Ospedale Bambino Gesù
THALASSEMIA
Notizie tratte da:
https://www.thalassemicibari.it/la-thalassemia/
La talassemia conosciuta anche come anemia mediterranea è una malattia genetica ereditaria che provoca una malformazione nella struttura dei globuli rossi.
Anemia Mediterranea, Malattia di Cooley, Beta Talassemia, Talassemia Major: termini diversi per indicare una grave forma di anemia emolitica, ossia di una malattia dei globuli rossi carenti di emoglobina, esposti a una continua e rapida distruzione.

La talassemia è nota anche come anemia mediterranea a causa della distribuzione geografica: la talassemia si verifica più spesso nelle persone di origine italiana, greca, medio-orientale, sud-asiatica ed africana.

In Italia ci sono circa 7000 pazienti di cui circa 800 in Puglia e circa 100 nella provincia di Bari.

La causa della talassemia è rappresentata dalla presenza di difetti nei geni dell’emoglobina, a livello del DNA: l’unico modo per contrarre la talassemia è ereditare uno o più geni di emoglobina difettosi dai propri genitori.
Le malattie genetiche sono causate da un’alterazione del patrimonio genetico di un individuo (DNA) che si evidenzia in difetti più o meno gravi; sono dette ereditarie quando i difetti del DNA si trasmettono attraverso le generazioni (non in modo contagioso!), coinvolgendo spesso più individui di una stessa famiglia.
Nei casi di queste tipologie di malattie genetiche non accade che tutti i componenti saranno malati, potrebbero esserci individui completamente sani ed altri portatori. La differenza si spiega osservando i geni che caratterizzano ogni individuo.
(Ognuno di noi possiede due geni (pezzetti di DNA) che portano
un’informazione sulla stessa caratteristica dell’individuo (ad esempio
il colore degli occhi).
Alcune di queste informazioni sono dette dominanti ed altre recessive
e differiscono appunto, in base alla caratteristica di riuscire a
“predominare” sull’informazione dell’altro gene. Facciamo un esempio:
“un gene degli occhi marroni” è predominante rispetto ad “un gene degli occhi azzurri” quindi un individuo avente entrambi questi geni avrà gli occhi marroni.
Per avere gli occhi azzurri sarà quindi necessario avere entrambi i geni con la stessa informazione: occhi azzurri.)

Questa spiegazione sta alla base della spiegazione su individui sani, malati e portatori per le talassemie .
In considerazione di questo, quindi, possiamo dedurre che 2 genitori sani potranno avere il 100% dei figli sani e 2 genitori malati potranno avere il 100% dei figli malati.

Le tappe evolutive nella cura della talassemia: ieri una malattia a prognosi funesta, oggi una condizione compatibile con una lunga sopravvivenza.
La terapia attualmente in uso consiste in frequenti trasfusioni di sangue, mediamente ogni 15 giorni. Queste comportano un accumulo di ferro nel cuore, nel fegato e nelle ghiandole endocrine che, per essere eliminato, necessita della somministrazione di farmaci ferrochelanti.
Nonostante i notevoli progressi della terapia convenzionale, non si può ancora parlare di guarigione definitiva dalla Talassemia e dalle emoglobinopatie.
Il percorso del progresso terapeutico non è completo: a breve termine i farmaci migliori, e a medio termine le terapie geniche, sono destinati a migliorare ulteriormente le prospettive di vita dei pazienti.
Quello che consente al paziente talassemico di vivere è ricevere per tutta la sua vita trasfusioni di sangue.
Il paziente talassemico esegue mediamente due trasfusioni di sangue al mese
e relative visite di controllo. Ovviamente questa procedura costituisce
un rimedio transitorio: i nuovi globuli rossi si legano comunque
all’emoglobina alterata, prodotta dal midollo osseo, e subiscono
invariabilmente il processo di distruzione precoce
Si presenta però il problema dell’accumulo di ferro
che si libera dall’emoglobina, passa nel circolo sanguigno e va a
depositarsi in vari organi — soprattutto fegato, cuore, pancreas —
danneggiandone inesorabilmente la funzione.

Quindi da quanto scritto sopra si evince quanto sia importante DONARE SANGUE, per cui:
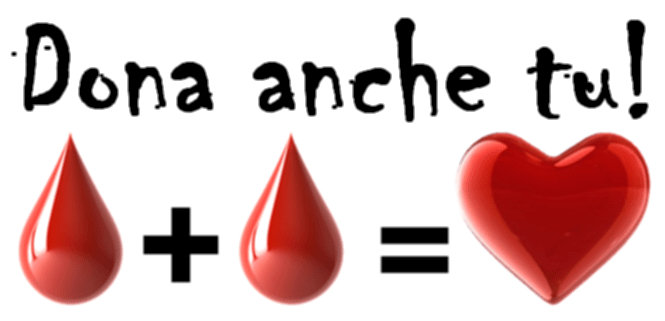
Il sangue è un insostituibile alleato negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche.



Se risulti idoneo, sei pronto per la tua prima donazione.
Per approfondire:
Rieducazione Posturale Globale
Rieducazione Posturale Globale

La Rieducazione Posturale Globale è un importante e rivoluzionario metodo riabilitativo che nasce da studi, ricerche biomeccaniche e neurofisiologiche del Professor Philippe E. Souchard.
Tale metodo prevede un riallungamento dei muscoli antigravitari. Questi sono sottoposti ad una attività contrattile continua e prolungata sia per assicurare la coattazione articolare dei vari segmenti corporei, sia per mantenere le posture e garantire l'equilibrio generale durante il moto.
La postura è la posizione che il nostro corpo occupa nello spazio grazie al tono e al pretensionamento dei muscoli statici. Essa dipende dal patrimonio genetico, dalla personalità e dalle afferenze esterne e di adattamento all´ambiente avvenute nel corso della nostra vita.
Quando l'organismo subisce un trauma, uno stimolo doloroso, un condizionamento a una postura fissa e prolungata nel tempo, reagisce innescando un meccanismo che contrae e accorcia la muscolatura tonica. Ciò consente di preservare dal "pericolo" le funzioni egemoni (importanti attività dell'organismo; quest´ultimo per mantenere l'integrità e la sopravvivenza delle stesse, sacrifica altre strutture determinando patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico).
L'obiettivo della R.p.g. è quello di ripristinare in maniera globale l'equilibrio statico e dinamico del corpo. Il trattamento di tale pratica è qualitativo, basato su posture di stiramento progressivo attivo dei muscoli statici e di natura fibrosa, interamente gestite dal terapeuta con la partecipazione attiva del paziente.
Souchard nell´elaborare questa tecnica prescrive osservanza e rispetto di tre principi fondamentali: individualità, causalità e globalità.
Il concetto di individualità chiarisce che la tecnica non può essere standardizzata, perché ognuno presenta adattamenti differenti in quanto soggetto attivo a livello conscio e inconscio dei propri riflessi.
Il termine causalità sottolinea come lo studio attento del paziente, biomeccanico e non solo, riesce sistematicamente a risalire alla causa del dolore, eliminando tutti i compensi messi in atto nel tempo.
Il principio della globalità si rifà all'oggettività: per ricreare l'equilibrio perduto è necessario lavorare attivamente su tutta la struttura osteomuscolare. È evidente, quindi, quanto sia importante combattere ogni tipo di patologia agendo sul corpo nella più totale globalità, al fine di eliminare dolore e causa del sintomo.
Sotto l'aspetto scientifico è estremamente importante studiare il paziente dal punto di vista della biomeccanica, aspetto che consentirà d'individuare i "tiranti muscolari" responsabili dello squilibrio strutturale.
Durante il processo di riprogrammazione posturale, la morfologia del paziente viene messa di continuo a confronto con un modello detto "biotipo di riferimento", nel quale le curve fisiologiche sono teoricamente esatte, con lo scopo di agire globalmente per riequilibrare tutto il sistema muscolare, allentando la tensione delle catene muscolari contratte.
La pratica della Rieducazione Posturale Globale può giovare al portatore di algie vertebrali di origine reumatologica o traumatica, al portatore di dolori e patologie articolari degli arti superiori ed inferiori, a colui che è affetto da contratture muscolari e/o squilibri vertebrali, a colui che presenta delle disfunzioni respiratorie inerenti a dei postumi di traumi e malattie neurologiche, a chi ha delle deviazioni e deformazioni ortopediche (piedi piatti, cavi, ginocchio valgo o varo, ecc.), alla donna in stato interessante, sia in termini preventivi che curativi, e a tanti altri soggetti.

[Fonte http://www.trapaniok.it/17919/Salute-trapani/rieducazione-posturale-globale]
--
Posted By marco to ECOLOGIC at 4/05/2017 12:42:00 PM
Perché l'avena combatte il colesterolo?
Sappiamo da tempo che alcuni cereali, come l'avena, sono alleati importanti nella lotta contro il colesterolo cattivo. Ma come riescono a contrastarne gli effetti? A spiegarlo è un nuovo studio dell'dell'Università del Queensland (in Australia), che ha identificato il preciso meccanismo con cui l'avena riduce la quantità di colesterolo nel sangue, aiutando così a limitare il rischio di malattie cardiache. Una vera e propria chiave di volta che potrebbe portare alla ricerca di altri cereali, come il grano, che abbiano proprietà ed effetti simili.
Quel che si sapeva fino ad oggi è che l'effetto benefico dell'avena è dovuto all'azione del beta-glucano, un polisaccaride solubile che esercita sul nostro organismo diversi effetti positivi, come migliorare la digestione a livello dello stomaco e promuovere la motilità intestinale. Inoltre, secondo uno studio canadese apparso poco tempo fa sul British Journal of Nutrition, il beta-glucano non sarebbe solo in grado di ridurre il colesterolo cattivo (Ldl), ma anche altri due importanti marcatori del rischio cardiovascolare: il cosiddetto colesterolo non-Hdl e l'apolipoproteina B, una proteina addetta al trasporto del colesterolo cattivo ai tessuti attraverso il sangue. "Il beta glucano non è contenuto solamente nell'avena, ma anche in molti altri cereali integrali", spiega Maddalena Lettino, responsabile dell'Unità operativa di Cardiologia dello Scompenso dell'ospedale Humanitas. "Per esempio, l'orzo, il riso integrale e anche la pasta o il pane prodotti con farine meno raffinate, tutti cibi che dovrebbero essere consumati da chi è affetto da ipercolesterolemia".
Quale fosse però il preciso meccanismo con cui i beta-glucani abbassano i livelli di colesterolo nel sangue rimaneva un mistero. Una delle teorie più accreditate proponeva che fosse dovuto alla capacità dei beta-glucani di "ripulire" il nostro organismo dalla bile prodotta durante la digestione. "Si pensava che il nostro organismo fosse così costretto a produrre nuova bile utilizzando il colesterolo, diminuendone così la quantità presente nel flusso sanguigno", spiega Purnima Gunness, una delle ricercatrici che ha collaborato allo studio.
Il nuovo studio invece ha prodotto risultati opposti. Lavorando su dei maiali, i ricercatori hanno infatti dimostrato che i beta-glucani nell'avena riducono la quantità totale di bile presente nell'apparato digestivo: dando ad alcuni degli animali questo cereale per 26 giorni, si è osservata una riduzione del 24% di acili biliari nel sangue. Al contempo, il colesterolo totale è diminuito del 34% e quello Ldl del 57%. Risultati che hanno permesso ai ricercatori di formulare una nuova ipotesi.
"Non siamo ancora perfettamente sicuri del perché, ma in presenza di questi polisaccaridi c'è molta meno bile nell'organismo. Questo significa che i grassi, che la bile aiuta a emulsionare, non vengono digeriti rapidamente o completamente", spiega la ricercatrice. E un minore o più lento assorbimento di grasso, sottolinea Gunness, è un fattore importante che permette di ridurre il colesterolo presente nel sangue. "Ora che sappiamo in che modo i beta-glucani hanno un impatto positivo sui livelli di colesterolo – conclude Gunness – potremo presto identificare altre fibre che possono avere un effetto simile".
--
Posted By marco to ECOLOGIC at 2/13/2017 10:44:00 PM
 |
| Pasta essiccata ad alte temperature (sinistra) e ad altissime temperature a destra (riconoscibile per il tipico colore ambrato) |