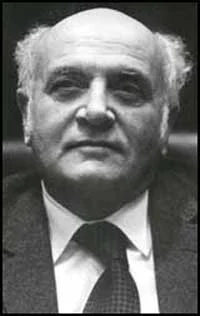Tutto quello che segue è stato copiato dal blog di Paolo Malaguti e ho deciso di pubblicare le sue riflessioni sull'Anniversario della Liberazione perchè le condivido completamente.
Paolo Malaguti ha pubblicato diversi libri: tutti da leggere; a fine maggio uscirà il suo ultimo romanzo - L' ULTIMO CARNEVALE.
Un libro e una riflessione

Sul baricentro tra la giornata mondiale del libro e il 25 aprile mi
permetto di suggerire una lettura tesa ed appassionante, e diversamente
non poteva essere, visto l'autore. Emilio Lussu scrive "Marcia su Roma e
dintorni" nel 31. Il libro venne rivolto, come annota l'autore nella
prefazione all'edizione italiana del 1944, "al pubblico francese e
angloamericano".
In questo libro si trova il resoconto in presa diretta del decennio
19-29, con particolare attenzione alla fase che culmina con la marcia su
Roma dell'ottobre del 1922. Lussu racconta l'ascesa del fascismo con
lucidità e, non di rado, con ironia; dà spessore alla narrazione con
nomi, fatti, voci dei protagonisti piccoli e grandi. Non è un saggio,
Lussu lo definisce "documento soggettivo ". Perché ho letto "Marcia su
Roma e dintorni"?
Per ricordarmi che la Resistenza, a ben vedere, dura lungo tutto il
ventennio, perché da subito ci fu chi si oppose e lottò e cercò di far
valere le proprie ragioni contro la dittatura nascente.
Per ricordarmi, ancora di più, che il fascismo non è nato forte, né
vincente. Mussolini, prima di sedersi alla Camera come presidente del
consiglio, il 16 novembre del 22, avendo ai suoi fianchi il generale
Diaz e l'ammiraglio Thaon di Revel, ha dovuto fare strada. Il fascismo
si è affermato anche perché gli è stato permesso. A tutti i livelli. Dai
prefetti che, come narra Lussu, in più parti d'Italia lasciarono
correre sui primi episodi di squadrismo, o appoggiarono apertamente le
camicie nere, fino al re che si rifiutò di firmare il decreto di stato
d'assedio proposto dall'on. Facta, decreto che con ogni probabilità
avrebbe messo la parola fine alla marcia su Roma.
Per ricordarmi, infine, che il "consenso" è fatto dalla somma degli
individui. Lussu dissemina tutto il libro di riferimenti ad amici,
deputati, docenti universitari, giornalisti, sindacalisti, reduci...
tutti fieri antifascisti della prima ora e, nel momento in cui il libro
uscì, il 1931, altrettanto fieri esponenti del regime.
Tra le figure di resistenti "ante 43" narrate da Lussu propongo quella
dell'onorevole Misiano. Già socialista, fu eletto nel 1921 nel partito
comunista: alla seduta inaugurale della XXVI legislatura del Regno
d'Italia fu aggredito da un gruppo di deputati fascisti e cacciato fuori
da Montecitorio. All'esterno Misiano venne aggredito da squadristi che
lo rasarono, gli sputarono addosso, lo insozzarono di vernice e lo
fecero sfilare lungo il Corso. Questo capita nel 1921, a Montecitorio, e
per le strade di Roma, in pieno giorno.
I motivi per cui Misiano era particolarmente inviso ai fascisti vanno
cercati, al di là dell'appartenenza al PCI, nel suo antimilitarismo,
nell'anti-interventismo, e nella sua condanna per diserzione nel maggio
del 1915.
Le polemiche che ogni anno interessano il 25 aprile (quest'anno in
particolar modo) sono l'ennesima conferma del cammino ancora lungo che
il nostro paese deve fare per costruirsi una memoria condivisa. Spesso
mi è capitato di riflettere su questo problema negli incontri con gli
studenti: un paese senza memoria condivisa è un paese diviso. Magari la
facciata dell'edificio è unita, ma le fondamenta sono separate. Il
cammino è difficile, perché tocca ferite ancora aperte, ma non mi pare
ci siano alternative.
E questo cammino credo debba partire dalla memoria, dalla ricerca, dallo
studio delle fonti e dei testimoni, e poi dal confronto.
Per questo, da insegnante, credo che negarsi al 25 aprile sia un'occasione persa.
Devo dire che, sempre da insegnante, le ottiche celebrative mi lasciano
perplesso, perché spesso la celebrazione implica l'agiografia, la
aproblematicità, un certo tasso ineliminabile di eroismo. Perché un
sedicenne dovrebbe trovare senso in qualcosa che è già dato, irrigidito
nella posa assoluta del monumento, illuminato da una luce diffusa e
candida che non lascia spazio a dubbi o a interpretazioni? Se sei un
eroe, dov'è la difficoltà nelle tue imprese? Se il giusto e lo sbagliato
sono ben divisi e riconoscibili di fronte a te, dov'è la difficoltà, la
tragicità delle tue scelte?
Se invece il 25 aprile, il 4 novembre, il 2 giugno vengono vissuti come
occasioni di commemorazione (cioè di "memoria assieme"), le cose
cambiano, e non di poco: si mostra, attraverso la memoria della Storia e
delle storie, quanto drammatica possa essere una scelta, quanto
difficile è capire, ogni giorno, dov'è il bene e dov'è il male. Si
capisce che una scelta non si compie mai una volta per tutte, ma poi va
riconfermata, o smentita, per il resto della nostra vita. Che le nostre
idee sono una cosa, e le nostre azioni spesso un'altra. Che lo Stato è
fatto da persone, e pertanto è soggetto all'errore. Che si può mettere
una data di fine a una guerra, ma poi i rancori, i conflitti, i dissidi e
le ferite vanno avanti per decenni.
Chiaro, fare tutto ciò non è facile, non è rapido, non è economico. Sono più veloci le altre due strade, ugualmente rischiose:
a) fingere che la storia sia solcata da chiari confini, da + e -
squadrati e lisci. Questa strada porta agli estremismi, e, di
conseguenza, ai muri e alle esclusioni.
b) rinunciare alla memoria, perché sono "altri" i problemi cui oggi
porre attenzione, piuttosto che un polveroso "derby" tra rossi e neri.
Questo porta all'ignoranza e, di conseguenza, al rischio della
ripetizione.
Nel libro di Gianrico Carofiglio "La versione di Fenoglio", da me letto subito dopo il libro di Emilio Lussu, sopra ricordato, il protagonista, Pietro Fenoglio, parla dei libri di Lussu:
" Ce n'è un altro suo che forse è addirittura migliore: Marcia su Roma e dintorni. La storia dell'avvento del fascismo con tutte le mediocrità, le vigliaccherie, le miserie, i voltafaccia. Lo so che sto per dire una banalità, ma è un libro che sembra scritto oggi per raccontare cosa succede ora in questo Paese."