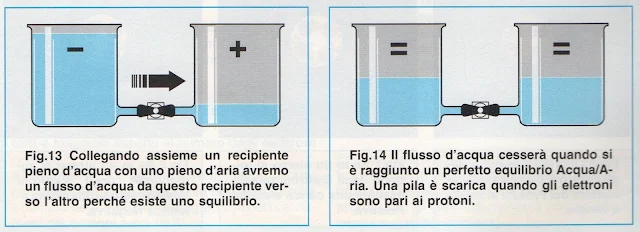GENERATORI DI TENSIONE
I più comuni generatori di tensione sono le pile che possiamo trovare in commercio informe e dimensioni diverse (vedi figura 37).
Ogni pila può erogare a seconda del modello tensioni da 1,5 - 4,5 - 9 Volt.
Esistono dei generatori di tensione ricaricabili, conosciuti con il nome di pile al nichel/cadmio oppure accumulatori al piombo, normalmente installati su tutte le auto, che generano una tensione di 12,6 Volt.
Esistono anche dei generatori in grado di trasformare la luce in una tensione è per questo motivo sono chiamati celle solari .
Alcuni generatori funzionano con il moto. Ad esempio la dinamo, installata su ogni bicicletta, o gli alternatori, installati sulle auto per ricaricare la batteria.
La dinamo installata nelle biciclette genera una tensione alternata.
In ogni appartamento sono presenti le prese elettriche dalle quali possiamo prelevare una tensione di 220 Volt alternata.
Il generatore di tensione chiamato trasformatore viene utilizzato in elettronica per ridurre la tensione alternata di rete dei 220 volt in tensione inferiore ad esempio 9 - 12 - 20 - 30 Volt.
La capacità di una pila viene espressea in Amper ora. Una pila da 3 Ah si scarica in un'ora se preleviamo 3 Amper, in due ore se preleviamo 1,5 Amper ed in 30 ore se preleviamo 0,1 Amper.
COLLEGAMENTI IN SERIE O IN PARALLELO
Gli esercizi che seguono permetteranno di constatare che cosa avviene se si collegano in serie o in parallelo due sorgenti di alimentazione.
Procurarsi due pile quadre da 4,5 volt, una lampadina da 6 volt completa del suo portalampadina e uno spezzone di filo di rame isolato in plastica per impianti elettrici.
Collegando i due estremi della lampadina ad una sola pila
(vedi figura 39) vedrete la lampadina accendersi.
Se prendete le due pile e collegate insieme i loro terminali positivi ed i loro terminali negativi e poi a questi collegate nuovamente la lampadina, anche in questo caso la lampadina si accenderà con la stessa intensità che si otteneva usando una sua pila.
Questo collegamento chiamato parallelo (vedi figura 39) non ha modificato il valore della tensione che rimane sempre di 4,5 volt, ma solo la sua potenza.
In pratica abbiamo raddoppiato l'autonomia della pila, vale a dire che se una sola pila poteva tenere accesa la lampadina per un tempo di 10 ore, collegando le due in parallelo riusciremo a tenerla accesa per un tempo di 20 ore.
Ora colleghiamo il positivo di una pila al negativo della seconda pila (vedi figura 40), poi ai due estremi delle pile collegate la lampadina e subito noterete un aumento della luminosità.
Questo collegamento chiamato serie, ha raddoppiato il valore della tensione che da 4,5 volt è salito a 4,5 + 4,5 = 9 volt.
Se per errore si collega il negativo di una pila con il negativo della seconda e sui due estremi positivi (vedi figura 40 a destra) colleghiamo la lampadina questa rimane spenta perché gli elettroni di identica polarità si respingono.
Lo stesso fenomeno si riscontra se si collega il positivo di una pila al positivo della seconda pila.
Importante
Noi possiamo collegare in parallelo anche 2, 3, 4 pile a patto che eroghino a la stessa tensione, quindi possiamo collegare in parallelo due o più pile da 4,5 volt oppure due o più pile che roghino 9 volt., ma non possiamo collegare in parallelo una pila da 4,5 volt con una da 9 volt perché la pila che eroga una tensione maggiore si scaricherebbe sulla pila che eroga una tensione minore.
Le pile con differenti tensioni si possono invece collegare in serie. Ad esempio se colleghiamo in serie ad una pila da 4,5 Volt una da 9 Volt (vedi figura 41) otterremo una tensione totale di:
4,5 + 9 = 13,5 volt
Se colleghiamo in serie tre pile, una pila da 4,5 volt, una da 9 volt ed una da 1,5 volt (vedi fig. 42) otterremo una tensione totale di:
4,5 + 9 + 1,5 = 15 volt.
In un collegamento in serie dovremmo però scegliere delle pile che abbiano una stessa capacità.
Ad esempio se la pila 4,5 volt ha un'autonomia di 10 ore, quella da 9 volt un'autonomia di 3 ore e quella da 1,5 volt un'autonomia di 40 ore, collegandole in serie cesseranno di fornirci tensione dopo solo 3 ore, cioè quando la pila da 9 volt che ha un'autonomia minore, si sarà totalmente scaricata.