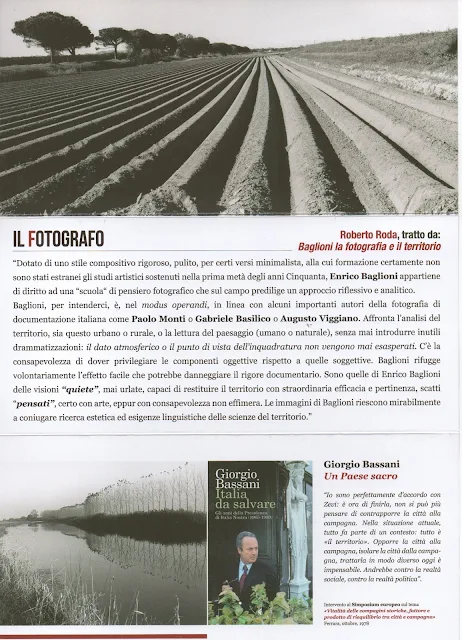PIACENTINI GIORGIO (1902 - 1969)
Ferrara omaggia la memoria di Giorgio Piacentini (1902 - 1969), Cavaliere del Lavoro, imprenditore e filantropo. Oggi è stata infatti intitolata a lui la rotatoria tra via Caldirolo e via Gaetano Turchi, che si trova a pochi passi da quella che fu un tempo la sede del calzaturificio Zenith, divenuto sotto la guida di Piacentini un'eccellenza manifatturiera e industriale del panorama produttivo italiano nel dopoguerra.
La cerimonia di intitolazione è in programma questa mattina, alla
presenza per l’Amministrazione Comunale dell’assessore Stefano Vita
Finzi e dei familiari di Giorgio Piacentini. La proposta di
intitolazione, su suggerimento di Carlos Dana, nipote di Giorgio
Piacentini, e del pronipote Giorgio Pizzirani, è stata approvata dalla
Commissione cittadina per la Toponomastica e dalla Giunta comunale e,
infine, autorizzata dalla Prefettura di Ferrara.
“Con questa intitolazione il Comune di Ferrara rende omaggio al
nome e alla storia di un personaggio che ha impegnato tutta la sua vita a
favore dell'industria ferrarese, anticipando concetti e azioni quali il
welfare aziendale e iniziative di carattere culturale e sociale,
rivolte a tutto il territorio, come con l’istituzione del Premio Estense
e del Cineclub Fedic Ferrara. Si tratta di un piccolo gesto, che ha per
noi però un grande valore: ricordare questa importantissima figura
attribuendogli un luogo di Ferrara, che tanto ha amato, vicino a quello
che è stato il suo universo professionale e umano. Ringrazio la famiglia
per essere presente oggi e per essersi prodigata nell’operazione di
intitolazione. L’augurio è che la figura di Giorgio Piacentini che possa
essere modello ed esempio per tutti noi”, così l’assessore Stefano Vita
Finzi Zalman, che ha ringraziato per il lavoro l’ufficio Toponomastica
del Comune di Ferrara.
Figlio di proprietari terrieri della Bassa Ferrarese, sposato con
Jolanda Buzzoni nel 1925, Giorgio Piacentini divenne industriale di
primo piano a seguito della scomparsa del suocero Edgardo Buzzoni,
avvenuta nel 1928. Raccolse infatti l’eredità imprenditoriale fondando e
diventando titolare della Zenith, insieme al cognato Andrea. Nelle sue
mani, infatti, l'azienda decollò diventando leader nel settore delle
calzature eleganti da uomo e da bambino, con esportazioni record in
America e non solo. Se nel 1929 le maestranze occupate sono 135, con una
produzione quotidiana di 160 paia di calzature, nel 1943 la Zenith
raggiunge i 510 dipendenti, raggiungendo una produzione di 2250 paia di
scarpe al giorno, di cui in alta percentuale sono di tipo militare.
La guerra fu un durissimo scoglio per i Buzzoni-Piacentini, come
riportano le cronache del tempo. Lo stabilimento viene bombardato più
volte e duramente, tanto che a fine del conflitto la fabbrica si trova
rasa al suolo, con trecento operai senza lavoro. Dopo la Liberazione
Piacentini affronta la ripresa dell’attività in locali di fortuna. Sul
finire del 1948 viene decisa la costruzione del nuovo stabilimento in
via Caldirolo al civico 84, che sarà ultimata nel 1950. Il nuovo
opificio dà da lavorare a 500 unità tra operai e impiegati con una
produzione giornaliera di circa 800 paia di calzature. “La complessa
costruzione industriale, sorta in un'area di 23mila metri quadri,
costituisce quanto di più razionale può riunire in sé uno strumento
produttivo di tale importanza. Perché non solo il dott. Piacentini ha
cercato con il riammodernamento degli impianti e una geniale
distribuzione del lavoro di organizzare il ciclo produttivo secondo i
più recenti dettami della tecnica moderna, ma si è parimenti preoccupato
che il nuovo complesso fosse dotato di servizi ausiliari e igienici:
mense, spaccio, ambulatorio medico e biblioteca, attuato con criteri
organici e confortevoli", come si legge in un interessante ritratto di
Piacentini, che emerge dai documenti conservati negli archivi della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Attenzione viene posta
anche al welfare aziendale, con l’invio in colonia per oltre 50 bambini
dei lavoratori “a totale carico della Zenith”, “anticipazioni ai capi
famiglia per l’acquisto di appartamenti” e donazione a ciascun operaio
di una ‘sporta’ contenente ogni genere di vettovaglia per Natale e
“cospicui premi in denaro”.
Ma il nome di Giorgio Piacentini non è solo legato alla vicenda
economica e imprenditoriale di Ferrara. Fu infatti sua l’idea, mentre
era presidente provinciale dell’Unione industriali, di fondare il Premio
Estense, la cui prima edizione si svolse nel 1965.
Anche il Cineclub Fedic Ferrara fu fondato qualche anno prima,
nel 1953, per iniziativa di Piacentini. Il circolo di cultura
cinematografica ferrarese fu riconosciuto come il migliore d’Italia già
pochi anni dopo, nel 1956 e anche nel 1957.
Istituì negli stessi anni anche un asilo infantile a Fossanova
San Marco, borgo che era divenuto residenza della famiglia Piacentini.
La struttura scolastica viene considerata tra le migliori della
provincia, con oltre 350 metri quadri di area coperta che consente
l'assistenza di 150 bambini della zona e dispone di sale per lavoro e
doposcuola.
Quanto sopra tratto da: