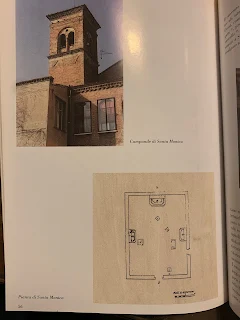In realtà è impossibile slegare la vicenda di Ravenna, e l'analisi della città, dallo scenario e dagli avvenimenti, umani e sociali, che in quegli anni sono stati emblematici non solo per Ferrara. Semmai dall'inizio del lavoro mi ha preso un assillo, che mi ha accompagnato poi durante la stesura del libro: il timore di aver stabilito, quasi inevitabilmente, un'empatia positiva con il personaggio, sino al punto di rischiarne l'apologia.
Non è accaduto, il libro rappresenta un mirabile esempio di equilibrio.
Merito anche della collaborazione preziosa di Paolo Ravenna. Non avevo mai sentito parlare del podestà ebreo di Ferrara, non sapevo nulla del suo legame con Italo Balbo. Stavo lavorando alla mia tesi, un giorno ricevetti la telefonata dell'avvocato, che mi propose di ricostruire la vicenda di suo padre. Mi ha subito conquistato, innanzitutto con la storia di quest'uomo tipico dell'Italia del suo tempo, quindi con la ricchezza dei materiali dell'archivio, infine per non avermi mai nascosto una sola carta, per la sorridente ossessione di andare a stanare in soffitta anche il più polveroso dei fascicoli. Tanti consigli sensibili, mai una censura. Mi sono sempre sentita libera di scrivere quello che vedevo e pensavo.
Torniamo da capo: chi era Renzo Ravenna?
Mi piace definirlo prima un italiano che un ebreo. Perchè faceva parte di quella generazione d'italiani che ha creduto onestamente nel fascismo, approdandovi spesso da sponde opposte. Anche Renzo Ravenna frequentava l'ambiente dei sindacalisti rivoluzionari e come tanti criticava il sistema giolittiano. Poi, durante la prima guerra mondiale, non partì come volontario: ne fortificò l'animo facendo emergere ancor più le sue doti di rigore morale e capacità di dialogo. Diversamente da Italo Balbo, non era uno sbandato: si laureò, si sposò, ebbe dei figli. La sua adesione al fascismo fu consapevole, non strumentale.
Ma quegli anni furono segnati, anche a Ferrara, da episodi aspri, terribili. Ravenna non se ne accorge?
Decise di assumere le redini del partito in città durante la crisi Matteotti e dopo l'assassinio di don Giovanni Minzoni. Non può certo passare per un ingenuo né mai ha mostrato di voler cancellare le proprie responsabilità politiche. Anche se nelle vicende più tragiche, non ebbe sicuramente parte attiva. Nel suo impegno non c'è comunque contraddizione, perchè nell'attività di podestà mise la cura di un amministratore rigoroso e di un leale servitore delle istituzioni.
Ha citato Balbo, con cui Ravenna ha condiviso un'amicizia durata una vita. Un rapporto che a tratti è stato addirittura mitizzato, a Ferrara. Molti, semplificando, hanno persino parlato di un filo ebraismo del gerarca.
Non corriamo. L'amicizia c'è stata ed è stata saldissima, anche se durante le mie ricerche non ho trovato uno straccio di carta, una lettera che ne testimoniasse l'intensità. Al di là di telegrammi, di bigliettini d'auguri, di piccole pezze d'appoggio era tutto, come dice lei, affidato al racconto o persino al mito; la realtà è comunque di due persone cresciute assieme, che frequentavano la stessa palestra e abitavano a pochi passi di distanza, con compagni di gioco comuni tra cui molti di religione ebraica. Due persone che negli anni continuano a vedersi e sentirsi, a collaborare e condividere tanti progetti per Ferrara. Tornando peraltro all'assenza di documentazione, vedo poco nella personalità di Balbo una sua attitudine a mettersi a scrivere lunghe, enfatiche lettere agli amici.
E l'amicizia con Ravenna come prova di un atteggiamento più morbido nei confronti del'antisemitismo?
Balbo non si è mai esposto pubblicamente e in modo concreto a favore degli ebrei. Forse non ha condiviso la scelta delle persecuzioni razziali, sicuramente nei confronti di Ravenna è stato un amico leale e in varie circostanze può aver anche portato il proprio aiuto, ma di qui a mettere in gioco la propria carriera e il ruolo politico ce ne corre. Le sue responsabilità, per ciò che avvenne in quegli anni a Ferrara e in Italia, non possono essere alleggerite.
Il suo libro è sapientemente suddiviso in due parti: la prima focalizzata sulla figura di Ravenna, la seconda incentrata sulla città.
Se l'avventura umana del podestà ebreo era sicuramente coinvolgente, lo studio di ciò che Ferrara rappresentava in quegli anni è stato lo spunto forse più intrigante. La storiografia pur sterminata sul fascismo, ha grandi lacune: mancava uno studio sull'operare concreto delle amministrazioni locali fasciste, e in questo senso la città che era stata culla del fascismo agrario rappresentava un caso rilevante, un possibile paradigma. Quale in effetti emerge alla fine del volume.
Per quali motivi?
Essenzialmente due. L'azione condotta nella riqualificazione urbanistica e la politica culturale. In entrambi i casi, non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi politici: nel primo, arginare la disoccupazione dilagante dei braccianti agricoli che rischiava di deflagrare in scontri cruenti. Di qui l'idea di varare una serie di opere pubbliche che, nel contesto urbanistico della città, hanno assunto una grande valenza. Penso al cosiddetto piano Contini, la riqualificazione di alcuni quartieri centrali tuttora di grande pregio.
Sul secondo versante, il discorso sarebbe amplissimo: la politica culturale, per il fascismo, era innanzitutto funzionale alla creazione del consenso. In città c'era un'esigenza in più, quella di ripulire l'immagine dello squadrismo ferrarese facendo leva sulle classi medie. Di qui il recupero della Corte Estense e il parallelismo, ben calcolato, tra il Rinascimento e il nuovo regime.
Che ruolo ebbero Ravenna e Balbo in questa operazione?
Decisivo. Assieme a Nello Quilici, direttore del Corriere Padano, elaborarono un modello basato sulla riproposizione di quel mito autoctono, incentrato sugli Estensi e la loro grandezza illuminata. Tra le grandi mostre e la riproposta del Palio, l'operazione ebbe un'indubbia valenza e rappresentò una sorta di autarchia alla ferrarese, distinta e distante dall'agiografia della romanità su cui si basava invece il fascismo. Altro particolare importante, a pilotare questa operazione fu essenzialmente il Comune, il fascio ferrarese non ne era in pratica coinvolto.
Pensa che questo contribuì a urtare qualche suscettibilità?
Per Ravenna non credo, di Quilici non so. Per Balbo ritengo che Mussolini gli riconoscesse in fondo la capacità di aver costruito questo mito autonomo, anche se forse il clamore delle iniziative un po' lo turbasse.
Restiamo al podestà ebreo. Arrivano le leggi razziali, poi la guerra e, nel '40, il brusco abbandono dela carica. Preludio agli orrori degli anni successivi. Come visse questa fase?
Come molti ebrei figli dell'emancipazione liberale, anche Renzo Ravenna visse la propria doppia identità, se così posso definirla, senza eccessive contraddizioni. Anche quando la situazione, dal '38, si fece oggettivamente più complicata, si sentiva relativamente sicuro. Lasciò la carica nel '40 e, pur di fatto costrettovi, dichiarò esplicitamente di ritenersi ancora al servizio, a disposizione dello Stato. E fino al '43, come molti altri ebrei italiani, sembrò addirittura non volersi rendere conto di quello che accadeva. Aveva rescisso il legame con il Pnf, di fatto non con le istituzioni e con la propria città. Poi la situazione precipitò, e dovette subire assieme alla famiglia la prova terribile e dolorosa della Shoah.
Il Ravenna che torna a Ferrara dopo la liberazione dei campi, chi è?
Un uomo ancora giovane ma stanco, profondamente provato. Ha capito perfettamente le responsabilità che ha avuto, e decide di non misurarsi più con la vita pubblica pur essendo un professionista stimato e benvoluto. Non farà mai ammenda, neppure in privato, delle vicende che lo hanno visto protagonista, ma è evidente che in grande riserbo patisce un enorme travaglio interiore. Muore a sessantotto anni, quando il cuore cede all'improvviso.
Nel libro questi eventi, al pari di molti altri, sono raccontati con il piglio della narratrice più che con il taglio della storica.
Che bel complimento! Non mi ritengo abile nella scrittura e in genere i miei testi sono fitti di note e rimandi. È un problema generale, e so di farmi qualche nemico dicendolo: spesso gli storici fanno a gara a scrivere in maniera oscura e arzigogolata, in modo che il lettore capisca poco.
Anche per questo il libro su Renzo Ravenna appare mirabile.
Non certo per le mie doti letterarie. Ritengo che sia frutto soprattutto dell'interesse suscitato dalla vicenda umana e politica del podestà ebreo, dell'eccezionalità del contesto sociale della città, oltre che dei contributi alla stesura del testo. Fondamentale anche il ruolo di Alberto Cavaglion, dell'Istituto per la Storia della Resistenza di Torino, che oltre a scrivere una illuminante postfazione mi ha dato consigli sia stilistici che di sostanza. Senza il suo apporto, e quello di Paolo Ravenna, forse i miei tre anni di lavoro non avrebbero raggiunto lo stesso risultato.
E la tesi che stava scrivendo al momento della fatidica telefonata dell'avvocato Ravenna?
L'ho completata, l'ho pubblicata, ma non ha avuto sinora alcuna recensione.
 |
| Renzo con i suoi artiglieri da montagna a Pin delle Fugazze nel giugno 1915 |
 |
| Il Podestà Ravenna, al centro, con Italo Balbo e Vittorio Emanuele III, (nei sedili posteriori) a Ferrara nel 1928 per l'inaugurazione della Torre della Vittoria |